
In rapido incremento, ma ancora troppo piccole e fragili per diventare il punto di svolta della nostra economia. Sono le startup italiane, afflitte dalla mancanza cronica di finanziamenti e dall’indifferenza delle grandi imprese, ma da cui arrivano nell’ultimo anno importanti segnali di vitalità. Esperti e studiosi sono divisi in materia tra chi giudica incoraggiante la performance del settore e chi, invece, sottolinea che non siamo ancora a un vero e proprio cambio di passo.
Ai nastri di partenza
A quasi 5 anni dal varo delle prime misure messe in campo dal Governo dell’epoca, con lo Startup Act, per stimolare lo sviluppo di un tessuto di imprese ad alta innovazione, chi propende per un bilancio moderatamente ottimistico può registrare il ragguardevole incremento di queste aziende (+31% a fine 2016 rispetto al 2015) e del numero degli occupati (+41%), l’alto tasso degli investimenti e la bassa mortalità delle nuove imprese (appena il 5%). Secondo gli ultimi dati rilevati a dicembre dal Ministero dello sviluppo economico, e presentati a febbraio, sono 6.745 le startup iscritte al registro speciale delle imprese, che danno lavoro tra soci e dipendenti a quasi 35mila persone. Si tratta quasi sempre di micro imprese: un’analisi sui bilanci 2015 (gli ultimi disponibili) evidenziava come a due anni dalla nascita del registro il 56,9% avesse un fatturato sotto i 100mila euro, 1/3 tra i 100mila e i 500mila euro, e appena l’8,9% superiore ai 500mila euro. Solo 67 tra queste imprese potevano vantare un fatturato superiore al milione di euro. Ma in che cosa sono impegnate le nostre startup? Più dei 2/3 forniscono servizi alle imprese – nella produzione di software e consulenza informatica, nella ricerca e sviluppo, dove 1 azienda su 4 è una startup, in attività collegate ai servizi all’informazione –, il 19,45% opera nei settori dell’industria in senso stretto, come la fabbricazione di computer e prodotti elettronici e ottici, il 4,31% opera nel commercio. Non mancano le eccellenze alcune delle quali segnalate da Forbes l’anno scorso. La rivista americana dopo aver analizzato l’esordio in salita delle nostre neo imprese, metteva in evidenza la crescita e il successo di alcune tra le migliori startup italiane. Tra queste,MusiXmatch, l’app che dà la possibilità di consultare i testi di 7 milioni di canzoni in 38 lingue diverse, con 30 milioni di utilizzatori e 10 milioni di euro raccolti, e il portale Waynaut che offre soluzioni di viaggio economiche unendo mezzi di trasporti tradizionali (metro, treno e bus) a sistemi innovativi (bike, car sharing, car pooling).
Una dura impresa
Per Stefano Firpo, a capo della direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del Mise, i provvedimenti messi in campo dagli Esecutivi che si sono succeduti nel corso degli ultimi quattro anni hanno avuto alcuni significativi risultati: «Se si pensa che la politica – spiega – ha investito circa 50 milioni di euro in questi anni e ha creato un sistema che vale 600 milioni di fatturato e 35mila posti di lavoro, i risultati non mi sembrano disprezzabili. Va poi considerato che questa politica è giovanissima – precisa –. Nasce alla fine del 2012 ed è operativa sostanzialmente da due anni. Il potenziale inespresso è ancora grande ». Con Industria 4.0, l’ultimo provvedimento in materia approvato con la legge finanziaria 2016, l’obiettivo è di creare una maggiore interazione tra Governo, enti di ricerca pubblici e privati e imprese. Basterà? Su questa nuova frontiera dell’autoimpiego, che per definizione dovrebbe essere votato all’innovazione e alla creatività, persistono problemi ancora gravi. Ad esempio, la dimensione delle neoimprese: «il 55-60% a due anni dalla costituzione – rileva Firpo – ancora fa fatica a fatturare. Non hanno una contabilità certificata, in mancanza della quale è praticamente impossibile raccogliere capitali». L’altro problema, che riguarda anche le startup più innovative, è il volume di investimenti in venture capital (capitale di rischio delle società), che pur in aumento del 24 per cento nell’ultimo anno, rimane tra i più bassi tra i paesi europei avanzati: appena 183 milioni di euro raccolti nel 2016 (erano 145 nel 2015) a cui si aggiungono circa una trentina di milioni di euro da fondi esteri. Per fare un confronto, gli investimenti totali verso le startup tedesche (2 miliardi) e francesi (2,7 miliardi) sono rispettivamente 10 e 15 volte superiori alle risorse che arrivano alle nostre dal sistema. L’Italia investe complessivamente meno di Danimarca, Svezia, Paesi bassi, Belgio, Irlanda e Svizzera.
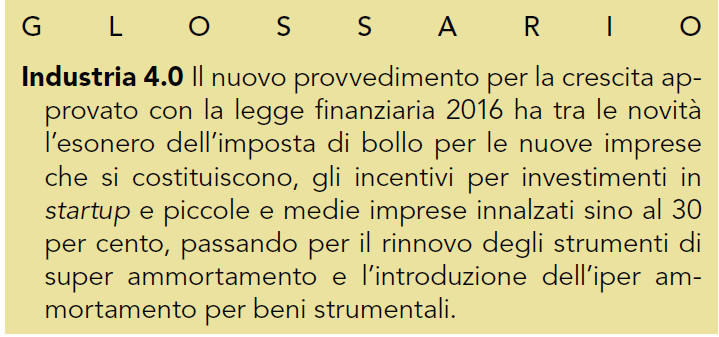
Di capitale importanza
«È positivo – afferma Antonio Ghezzi, direttore dell’Osservatorio startup hi-tech del Politecnico di Milano – riscontrare che aumentano gli investimenti sia degli investitori formali (aziende consolidate, fondi di investimento e finanziarie regionali) che informali (manager che hanno un capitale da investire in una startup interessante o Family office e piattaforme di crowdfunding). Tuttavia va rilevato che i venture capital investono solamente 1/7 di quanto fanno le controparti tedesche e circa 1/6 di quanto finanziato in Francia. Parliamo di poco più di 600 startup hi-tech finanziate tra il 2012 e il 2016». La speranza è dunque che aumentino gli investimenti. «Da imprese consolidate, attraverso fondi di Corporate venture capital veri e propri, oppure tramite finanziamenti diretti – precisa Ghezzi –. Questo richiederà tuttavia una crescente apertura e propensione da parte delle imprese, spesso rigide, verso il caos organizzato rappresentato dalle startup». Il problema principale sta proprio qui: mentre in Germania o Francia le grandi aziende scommettono sulle startup, in Italia ancora non lo fanno. «Il venture capital in Italia è identificato con la finanza speculativa e super rischiosa – riprende Firpo –. In realtà è un mondo gestito dalle imprese e finché non avremo imprenditori veri che vanno a cercarsi le startup e le utilizzano per fare impresa, le nostre aziende in erba continueranno a fare fatica per trovare capitali. Oggi, quando hanno i primi successi, tendono ad andare all’estero a raccogliere il denaro necessario».
Fino in fondo
Una svolta potrebbe arrivare dai fondi di investimento che hanno rastrellato capitali e che nei prossimi anni dovrebbero essere pronti a riversarli sultessuto delle nostre startup innovative come, ad esempio, Primomiglio sgr, la società di gestione del risparmio fondata da Gianluca Dettori, che investirà 50 milioni di euro in 200 startup nei prossimi cinque anni o 360 Capital Partners che ha già in portafoglio Musement (piattaforma per prenotare musei, tour, escursioni in tutto il mondo) e DoveConviene (piattaforma on line che informa gli utenti su sconti, promozioni, novità nei punti di vendita vicini), in assoluto la più finanziata. Ma un segnale importante sta arrivando anche dagli atenei e dal settore pubblico. 6 scale-up italiane vengono fuori, infatti, dagli spin-off universitari del Cnr di Lecce (Echolight), dell’Istituto Italiano di Tecnologia (Movendo), del Politecnico di Milano (Zehus & Leaf Space), dell’Università di Milano (Newronika) e dell’ Università di Pisa (BioBeats). Le spin-off rappresentano il 15% di tutte le scaleup italiane, mentre in Francia siamo intorno al 5%. Inoltre sta cambiando in modo sensibile anche la politica verso le startup, seguendo l’esempio di altri Paesi: basti pensare che tra gli 11 fondi più attivi in Europa 8 si avvalgono di risorse pubbliche. «Per rafforzare il proprio ruolo nel favorire la crescita delle startup – rileva Ghezzi – nel 2015 il Governo italiano ha modificato il suo approccio al finanziamento pubblico di quelle innovative: dalla concessione di finanziamenti a fondo perduto a una gestione degli investimenti attraverso l’investitore formale Invitalia Ventures che garantisce una combinazione tra capitali azionari e supporto manageriale ». Invitalia Ventures, che ha avviato le sue attività circa un anno fa con i primi finanziamenti, si appresta a riversare una tranche di 50 milioni di euro sul mondo delle startup e sarebbe allo studio un altro fondo pubblico da 200 milioni di euro. La strada delle startup è solo all’inizio.
Ben avviate
La nazione delle startup è Israele.
Un piccolo paese, con appena 8 milioni di abitanti, ma con una tale propensione a sviluppare nuove imprese innovative da essere definito Startup Nation. Il paese in questione è Israele, capace di catalizzare sulle sue startup – oggi 4.800 – investimenti per 2,7 miliardi di euro, un dato pari, per intenderci, a quello francese e 15 volte superiore a quello italiano. Qual è il segreto del successo di questo paese? Innanzitutto il ruolo significativo – e inimmaginabile per l’Europa – del suo esercito, in assoluto tra i più tecnologici al mondo. Viene da lì buona parte della tecnologia, ma anche dei nuovi imprenditori che sviluppano progetti di cybersecurity, computer vision, intelligenza artificiale, deep learning, machine learning. La leva obbligatoria ha, infatti, permesso all’ultima generazione di israeliani di costruire relazioni, il network necessario allo sviluppo di nuove imprese. Poi ha un ruolo significativo il mondo accademico – Israele ha alcune delle Università più avanzate del mondo – e una politica pubblica che ha investito molte risorse nel lancio di nuove iniziative imprenditoriali. Negli anni Settanta il governo ha creato i primi venture capital che hanno permesso a compagnie private di avere denaro pubblico e investirlo in startup. Inoltre, l’arrivo di un milione di immigrati russi negli anni Novanta ha fornito la professionalità e le competenze di ingegneri e personale altamente specializzato. Da molti anni lo Stato israeliano finanzia l’85 per cento del capitale necessario per la creazione di nuova azienda che viene restituito solo se l’impresa ha successo, cosa che ha spinto molti investitori internazionali a investire in Israele. Oggi sono circa 300 le forme di cooperazione internazionale che hanno un centro di ricerca e sviluppo in Israele.
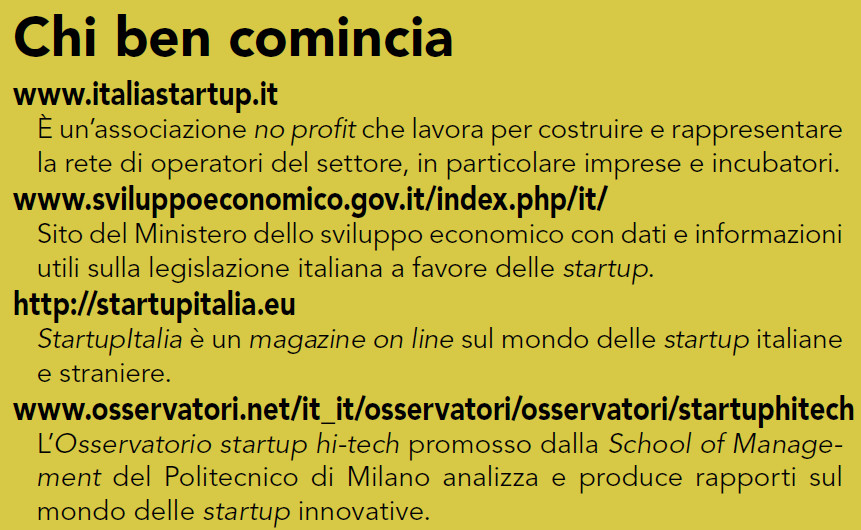
Problemi di crescita.
Perché le startup italiane faticano a cambiare passo e a competere nel mondo ce lo spiega il presidente dell’organizzazione no profit Italia Startup Marco Bicocchi Pichi.
«Le nostre startup brillano in molti casi per competenze e creatività, ma fanno fatica a crescere per la nostra incapacità di coordinarci e agire con metodo e per la mancanza di risorse». A sostenerlo è Marco Bicocchi Pichi, presidente dell’organizzazione no profit Italia Startup.
Presidente, che cosa pensa dei dati che danno in crescita le startup innovative in Italia?
«È senz’altro un aspetto positivo che registra un generale incremento nella voglia di fare impresa. Ma c’è un aspetto che preoccupa: le nostre startup innovative rimangono dal punto di vista della struttura di capitale molto simili alle altre, troppo piccole per creare vera ricchezza e occupazione. Molte di queste non hanno la caratteristica di fondo che dovrebbe avere una startup, una crescita rapida che la metta in condizione di competere nel mondo. Quelle che superano il milione di fatturato, e cioè il livello oltre il quale si lascia la condizione di microimpresa, sono ancora poche. Da questo punto di vista, gli obiettivi originari lanciati con Italia Startup nel 2012, cioè invertire la rotta dei cervelli in fuga dando opportunità reali ai nostri talenti di fare impresa, non sono stati ancora raggiunti».

A che cosa possiamo addebitare questa difficoltà?
«Accenno qui a due problemi solo all’apparenza distinti. Da un lato, c’è una cronica mancanza di risorse. Per fare il salto in grado di renderla competitiva sul mercato internazionale, una startup ha bisogno di molti soldi. Ma i nostri tre più grandi incubatori, pur capaci di acquisire competenze e professionalità di qualità, capitalizzano in borsa appena 100 milioni di euro. La dimensione finanziaria è inadeguata. Morale: siamo in grado di far nascere startup di ottimo livello, ma non abbiamo i soldi per vedere se queste aziende possono crescere e affermarsi sui mercati internazionali».
Veniamo all’altro aspetto.
«Circola nel nostro paese molta liquidità, ma il capitalismo italiano, storicamente consolidato attorno a grandi famiglie, vede come estranea la cultura del rischio e preferisce investimenti sicuri. In Germania e in Francia, al contrario, il ruolo dei grandi gruppi ha una significativa ricaduta sulla vitalità delle loro startup ed è uno stimolo all’innovazione. È un dettaglio non trascurabile anche in chiave di investimenti esteri: i fondi stranieri si fidano poco di cose che noi stessi non sosteniamo. E quando si muovono in Italia lo fanno a quel punto in termini di concorrenza portandoci via realtà promettenti».
Pensa che il Governo faccia abbastanza?
«Industria 4.0 è un buon provvedimento, ma a condizione che tutti gli attori, dalle imprese alle finanziarie regionali, facciano la loro parte. La politica degli ultimi Governi ha fatto molti passi in avanti. Penso che ora occorra una maggiore concertazione tra gli attori in campo, una maggiore capacità di programmare il futuro».

Giovani coop
Come Coop ha favorito la nascita di nuove, giovani, imprese cooperative. Il progetto Coopstartup Unicoop Tirreno.
304 iscrizioni, 700 persone coinvolte, 138 progetti ammessi alla prima selezione. Ha preso il via così nel 2015, in occasione del 70° compleanno della Cooperativa, il progetto Coopstartup Unicoop Tirreno, sviluppato insieme a Coopfond (il fondo mutualistico di promozione e sviluppo di Legacoop), allo scopo di favorire l’incremento dell’occupazione giovanile tramite la creazione di imprese cooperative. Rivolto a gruppi di almeno tre persone, in maggioranza di età inferiore a 35 anni, il bando è partito nel maggio 2015 e si è sviluppato in diverse fasi (promozione, prima valutazione, incubazione, selezione) fino ad arrivare, a marzo 2016, alla premiazione dei 5 scelti tra i 26 che avevano completato il percorso con la consegna del business plan.
Questi i vincitori (tutti primi classificati): Gruppo Erse, servizi di monitoraggio ambientare (Toscana), Virginia, linea di abbigliamento maschile per donne (Lazio), TripTalent, piattaforma web-based che aiuta i viaggiatori a costruire itinerari personalizzati (Campania), Multicoopter, servizi di videoriprese con uso di droni (Umbria), Tobilì cucina in movimento, servizio di catering etnico (Campania). La qualità dei progetti presentati ha spinto la commissione valutatrice ad assegnare ulteriori tre premi speciali: Vascitour, vendita di brevi periodi di vacanza esperienziale a Napoli (Campania), Urban Trees Management, recupero di zone degradate con la realizzazione di aree verdi boschive seminaturali (Lazio), Snack Amiata, produzione di barrette proteiche e bevanda analcolica a base di farina di castagne (Toscana).
I 5 progetti vincitori hanno ottenuto un contributo di 15mila euro a fondo perduto con l’accompagnamento post startup nei 36 mesi successivi alla costituzione in impresa e la possibilità di accedere a un finanziamento fino a un massimo di 150mila euro da parte di Coopfond. Il riconoscimento per ciascuno dei vincitori dei primi speciali è stato invece di 10mila euro a fondo perduto

